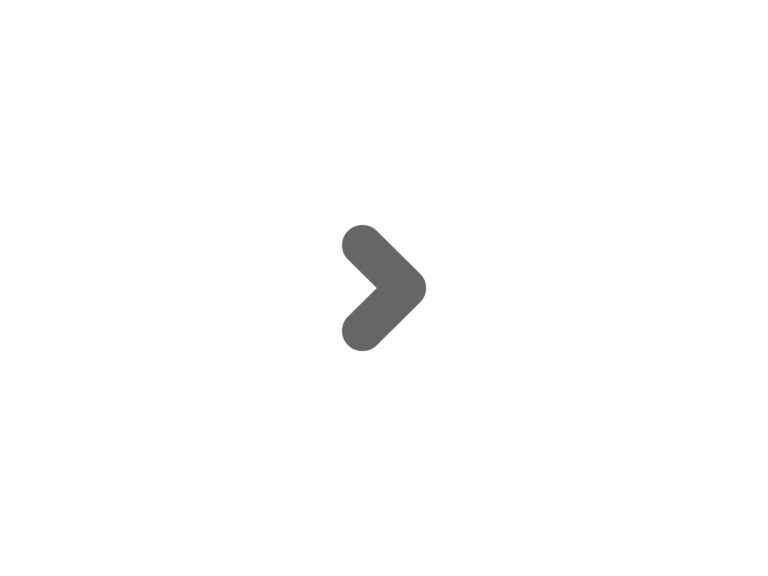Un primo abbozzo di significato
Il termine su cui intendiamo qui soffermarci è “cittadinanza”: lo si farà innanzitutto circoscrivendone il senso in riferimento alla sua etimologia, per poi verificare la tenuta del significato (la faccia interna del segno) rispetto al processo di storicizzazione a cui il significante (la faccia esterna, l’elemento formale) naturalmente è soggetto. Lo scopo non è quello diconfermare o di destituire il contenuto espressivo per come rilevato, ma di considerare adeguatamente i processi osmotici che ogni lemma intrattiene con l’ambiente in un preciso momento culturalmente, socialmente, economicamente connotato e, seoccorre, contribuire a qualificarlo di conseguenza, in un susseguirsi di operazioni di confinamento e di sconfinamento pensateora come esercizio di resistenza, ora come forma di resa alla sua magmatica complessità.
Nel vocabolario Treccani il termine “cittadinanza” è derivato di “cittadino” (a sua volta proveniente da “cittade”, varianteantica di “città”), con il quale si indica il vincolo di appartenenza di un individuo a uno Stato, o, nell’uso comune, a una città. Più esplicita, in tal senso, la spiegazione contenuta nell’enciclopedia Treccani, dove si legge come questa condizione di appartenenza comporti specifici diritti, tra cui vanno annoverati, in particolare, i diritti politici, che attribuiscono a tutti i cittadini la titolarità alla partecipazione alla vita politica dello Stato (per esempio il diritto di voto) e all’esercizio di cariche pubbliche, ma anche precisi doveri, quali l’obbligo di fedeltà e di difendere lo Stato nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. L’Accademia della Crusca specifica, inoltre, come l’interpretazione di questa particolare condizione (status) del «soggetto di fronte all’ordinamento giuridico o, se si vuole, allo Stato persona», oltre che costituire il presupposto per l’attribuzione di un insieme di diritti e di doveri, sancisca anche l’appartenenza al popolo (demos), quale elemento costitutivo di l medesimo Stato. Aggiunge, ancora, come il riconoscimento di diritti e di doveri di natura essenzialmente pubblicistica segnali, sia pure implicitamente, una differenza di trattamento rispetto alla posizione nell’ordinamento propria del “non” cittadino, lo straniero, oggi comunque significativamente ridotta per via dell’attribuzione anche a questi di una molteplicità di diritti ritenuti espressione di un patrimonio irretrattabile della persona umana (Carnevale, 2022).
Lo spettro semantico sembra così rimandare a una medesima idea di “appartenenza”, il cui senso è chiaramente delimitato, però, dal riferimento rispettivamente a Stato, città e popolo. Valutare se oggi questa connotazione polisemica sia sufficiente èlo scopo di questo contributo (discorso della cittadinanza). Di sicuro, tuttavia, questa prima mappatura di significato è il precipitato di un’evoluzione del termine1 mai lineare, che procede per inaspettati salti e clamorose marce indietro (discorso sulla cittadinanza), un percorso spesso accidentato e ancora in corso, di cui si avrà cura di tratteggiare gli sviluppi futuri desiderabili oltre che possibili (il discorso per la cittadinanza).
Il discorso sulla cittadinanza
Il discorso sulla cittadinanza come bene passibile di distribuzioni diverse e, quindi, in maniera specifica, sui criteri di una tale distribuzione è stato caratterizzato da un andamento che soppianta l’idea di una progressione lineare, graduale eininterrotta di avanzamento, per descrivere un ben più realistico svolgimento caratterizzato da lunghi periodi di stasiintervallati da improvvisi e rapidi eventi, ai quali è spesso possibile attribuire il carattere della innovatività ma non semprequello della desiderabilità. Vašák (1984, cit. in Caruso, 2014) vi identifica tre fasi, scegliendo come criterio il raggiungimento di importanti tappe nel riconoscimento dei diritti umani che
«almeno per le democrazie costituzionali e per l’Unione Europea, non sono decorazioni esornative, ma le strutture portantidell’identità collettiva e la condizione di legittimità dell’ordinamento» (Costa, 2023, p. 51).
La prima fase è quella dei diritti di prima generazione (civili e politici) relativi alla libertà. Il loro esordio si fa risalire all’affermazione della polis greca, in cui la cittadinanza era attribuita a coloro che nascevano da genitori entrambi liberi e cittadini, mentre l’esercizio dei diritti civili (cioè i “diritti di libertà” che comprendono diritto alla vita, alla sicurezza e alla proprietà, alla libertà di pensiero e di religione, di riunione e di movimento) iniziava, in genere, alcompimento del ventesimo anno di età, subordinatamente al soddisfacimento di requisiti quali il possesso di beni fondiari e il raggiungimento di una soglia minima di censo. Nelle federazioni politiche, come la Lega Acarnana, Achea, Beotica e Licia, icittadini godevano di una doppia cittadinanza, sia federale che municipale. In ogni caso, lo status di cittadino era permanentee poteva essere revocato esclusivamente per atimìa2 o in caso di esilio. Il concetto di cittadinanza si consolidò ulteriormentenella tradizione giuridica romana, dove il termine civilitas denotava l’appartenenza alla civitas: si trattava di uno statogiuridico che copriva sia il livello dello ius civile sia quello dello ius gentium, entrambi riservati a esseri umani liberi e maschi, con la sola eccezione dei membri delle comunità legate a Roma da un foedus aequum, purché, tuttavia, rinunciassero alla cittadinanza originaria. In particolare, durante l’epoca repubblicana, solo i cives godevano del diritto di voto nelleassemblee popolari, potevano compiere atti solenni regolati dallo ius civile, esercitare la patria potestas e il dominium su beni e schiavi. Con l’espansione territoriale di Roma, la cittadinanza fu progressivamente estesa ad altre popolazioni e, infine, con la Constitutio Antoniniana, fu riconosciuta a tutti gli uomini liberi dell’Impero: il dibattito sulla cittadinanza perse, così,rilevanza e attrattiva, rimanendo, di fatto, in ombra durante tutto il Medioevo e buona parte dell’età moderna, fino alla fine del xviii secolo.
I diritti di seconda generazione (sociali), spiega ancora Vašák (1984), maturano a seguito del forte impulso offerto da quel complesso di eventi politici e sociali estremi noto come Rivoluzione francese che, ispirandosi ai concetti di libertà, uguaglianza e sovranità popolare, restituisce alla cittadinanza la centralità precedentemente perduta: la figura del sudditoviene, infatti, rimpiazzata da quella del citoyen, membro della nazione e detentore della sovranità3, che dà un forte impulso alla nascita della democrazia intesa come «società dei cittadini» (Bobbio, 1990, cit. da D’Alessandro, 2006). Persiste,tuttavia, ancora una frattura tra lo status di cittadino e l’esercizio dei diritti politici, riservati ai soli citoyens actifs, cioè ai piùabbienti: tale disuguaglianza sarà superata solo molto tempo dopo, con l’avvento del suffragio universale e l’affermazione della sovranità popolare.
Si dovrà attendere, poi, il 1948, spiega D’Alessandro (2006), con la promulgazione della Dichiarazione universale deidiritti dell’uomo adottata dall’Assemblea generale dell’onu, per registrare un altro importante cambio di passo nel camminoverso l’eguaglianza: la formulazione esplicita dei diritti umani (Costa, 2023) e l’affermazione della loro universalizzazione4 come ideale comune da raggiungersi per tutti i popoli e per tutte le Nazioni. Si amplia, così, di fatto il concetto di cittadinanza– che non si limita più alla fruizione dei diritti civili, politici e sociali legati a un’entità statuale, ma si estende al godimento dei diritti fondamentali attribuibili a ogni essere umano – e con questa estensione sembrano scolorare i margini che tradizionalmente lo avevano distinto dal suo contrario, la condizione dello straniero. Come spiega Costa, infatti, «il dato formale della cittadinanza cessa di essere un parametro esclusivo, mentre acquisiscono un nuovo e autonomo risalto la“fattuale”, sostanziale permanenza dei soggetti sul territorio nazionale e il loro coinvolgimento nell’interazione sociale e nelladinamica produttiva» (ivi, p. 50). E, riprendendo il pensiero di Caruso (2014), propone una revisione della concezioneottocentesca di cittadinanza, suggerendo di ripensarla come un “plesso di funzioni”, in cui la condizione del cittadino assumeuna “configurazione a geometria variabile”: essa non è più oltre riducibile alla dicotomia tra inclusione ed esclusione (ovverotra cittadino e straniero, dentro e fuori), bensì si dispiega in molteplici dimensioni dell’esperienza individuale e collettiva, inragione delle quali il cittadino si definisce, dunque, non solo come elettore, ma anche come produttore, residente, consumatore e contribuente.
Nell’iter descrittivo dell’evoluzione difficile del costrutto di cittadinanza non può mancare, suggerisce Caruso (2014), l’ultimo, importante traguardo in ordine al riconoscimento di una nuovatipologia di diritti, che va ad aggiungersi a quelli politico-civili ed economico-sociali: i diritti collettivi (Ferrajoli, 2007), vale a dire diritti il cui esercizio è intrinsecamente collettivo, con particolare riferimento a quelli connessi alla tutela della qualitàdell’ambiente e, in parte, a quelli afferenti al diritto all’informazione, che vengono oggi ripensati in termini di “beni comuni”. È, questa, la terza fase dell’evoluzione del concetto di cittadinanza, quella della tutela dei diritti di terza generazione (ambiente e informazione)5 (Vašák, 1984, cit. in Caruso, 2014).
A ben guardare, dunque, la storia dell’evoluzione del costrutto di cittadinanza si dipana lungo un unico, tortuoso percorso,scandito da tre tappe fondamentali sostanzialmente animate da due modelli di cittadinanza antitetici, per quanto basati sulle medesime strutture giuridiche fondamentali (doveri e diritti): «uno pre-moderno, basato sui doveri degli individui neiconfronti del sovrano, della comunità, del gruppo di appartenenza; l’altro moderno, basato invece sui diritti individuali e sullatutela delle prerogative dei soggetti contro il potere dello stato e degli altri gruppi sociali» (Greco, 2014, p. 145). E, sottostantea essi, la medesima lotta millenaria tra due forze di segno opposto: a quella che, sia pure a partire dalla diversità di questimodelli, ha spinto e spinge nella direzione di una tutela di doveri e diritti se ne contrappone un’altra che ha spinto e,sorprendentemente in questo tempo storico, spinge tuttora, nella direzione opposta, negandoli e mortificandoli. Espressione dei totalitarismi che hanno punteggiato la nostra storia (fascismo, nazismo, stalinismo, ecc.), questa forza di negazione si configura non solo come un ordinamento politico in cui risultano compromesse tanto le libertà politiche quanto quelle civili, ma altresì come un assetto caratterizzato dal controllo e dalla regolamentazione onnicomprensivi (Forti, 2010), che sfidanosistematicamente quella profondità e radicalità del bene – al quale ostinatamente e in maniera contraria riconosciamo essere ontologicamente votato l’uomo – in un modo che non possiamo non definire con Arendt (2001) come “estremo”.
Ancora, alla luce di quanto suggerito dalla ricostruzione in senso diacronico, è possibile individuare le dimensioni che hanno caratterizzato il concetto di cittadinanza (Leydet, 2011; Caruso, 2014) lungo il corso del tempo, così distinguendo unacittadinanza giuridica, intesa come uno status garantito da diritti legalmente tutelati, una cittadinanza come agency politica,ossia la capacità di partecipare attivamente alla vita istituzionale, e una cittadinanza che rimanda ad aspetti che sono a untempo psicologici, la cittadinanza come “sentimento” (Shotter, 1993), sociologici, come adesione a uno specifico set dipratiche che definiscono una persona come membro di una determinata società (Turner, 1993), e culturali, come forma di lealtà verso un insieme di conoscenze, competenze e credenze di un popolo o di un gruppo etnico.
Il discorso della cittadinanza
Posto che la direzione da seguire sia definita in modo chiaro e inequivocabile dalla norma – un mondo libero dalle contraddizioni interne che rischiano di comprometterne la sopravvivenza, finalmente sostenibile, strutturato attorno alla necessità di superare le profonde disuguaglianze che lo affliggono garantendo a ciascun individuo eguali opportunità dibenessere, salute e istruzione –, non resta che chiedersi quanto di questo impianto concettuale resista alla complessità dell’attuale contesto mondiale (Costa, 2023). Il discorso sulla cittadinanza si sposta, quindi, su un altro piano e si fa discorso della cittadinanza, che riguarda il particolare modo «sviluppato da una determinata società per rappresentare l’individuo e ilsuo rapporto con l’ordine» (Costa, 2005, p. 30). E il discorso della cittadinanza in questo tempo storico è, essenzialmente, un discorso che riguarda la cittadinanza globale e le tendenze che la contraddistinguono (globalizzazione, complessità, babele di informazioni e disorientamento), che si traducono in una sola e grande sfida contro la frammentazione e i processi che la caratterizzano, ben rappresentati da Morin:
I frammenti umani sono interdipendenti, ma l’interdipendenza non crea la solidarietà; sono in comunicazione, ma le comunicazionitecniche o commerciali non creano la comprensione; l’accumulo delle informazioni non crea la conoscenza, e l’accumulo delle conoscenze non crea la comprensione. Nello stesso momento in cui si sviluppano innumerevoli processi di unificazione (tecnici, scientifici, di civiltà) si realizzano formidabili disgregazioni, regressioni, chiusure (nazionali, etniche, religiose) (Morin, 2005, p. 162).
Secondo Morin, la globalizzazione ha stabilito le basi infrastrutturali – sia comunicazionali che economiche – per unasocietà-mondo. Tuttavia, l’assetto economico neoliberale che ha originato queste infrastrutture ne ha ostacolato un utilizzo funzionale a favorire il passaggio da un universalismo astratto a uno concreto, ossia finalmente in grado di contemplare insieme nello stesso discorso il diverso e l’uno, il singolare e il generale. Così, l’universalismo dei diritti umani finisce conl’essere negato come possibilità dalla sua stessa ipostatizzazione, rea di isolare a tal punto le caratteristiche comuni dielementi particolari da finire col rendere la diversità talmente sfumata da scolorare. Dandogli una veste universale, si è,dunque, drammaticamente finito con l’occultare una concezione dell’uomo particolare, preludio, questo, a ogni forma di negazione dell’essenza umana e all’adozione di una logica dis-umanizzante, responsabile della sempre maggiore enfasi suiparticolarismi locali, sulle narrazioni identitarie e sulle sovranità esclusive e conflittuali. La cittadinanza, in quanto capacità di essere solidali e responsabili, si misura per questa via con la necessità antropologica dell’uomo contemporaneo di “sapersi pensare” all’incrocio di più dimensioni identitarie concentriche e plurali (Morin, 2001), sforzo derivato dalla consapevolezza di abitare in un mondo “piccolo” e fortemente interconnesso, cui fa seguito la difficoltà di fare appello a una narrativaadeguata allo scopo, ossia capace di tenere insieme l’identità locale, l’identità europea e l’identità planetaria6.
Alla percezione divenuta finalmente chiara della natura ecologica della mente, che Bateson (2000) descrive come il modoin cui individuo, cultura e ambiente inter-retroagiscono tra di loro, segue la consapevolezza della necessità di un’ecologia dell’azione (Morin, 2005): la coesistenza di queste identità plurime nella medesima persona presuppone, infatti, che lagenerica capacità di essere solidali e responsabili – implicita nel costrutto di cittadinanza – si concretizzi, de facto, nell’esercizio di diritti e doveri che derivano dalla titolarità di questo status a livello nazionale (cittadinanza nazionale),europeo (cittadinanza europea) e planetario (à la Morin, cittadinanza planetaria). Quest’ultima, in particolare, avocando a sé quale suo ambizioso scopo quello di promuovere una società-mondo, presuppone una trasformazione antropo-socialeprofonda, una metamorfosi, che faccia appello all’attitudine tutta umana a generare e a rigenerare le proprie qualità: una natura descrivibile come “generica” (ivi; Pezzano, 2012).
A differenza dell’animale, la cui essenza è dentro, si basa, cioè, su abilità iscritte nella sua costituzione biologica innata, epertanto è predeterminata e vincolante, l’uomo, infatti, non è “genetico”, non ha un’essenza specifica che si trasmette pereredità naturale, e non è nemmeno “degenere”, perché non è privo di natura e, in quanto tale, infinitamente duttile emalleabile, ma ha un’essenza aperta che gli consente di istituire forme diversissime di socialità con l’esterno, con il fuori da sé, nelle relazioni sociali con gli altri umani. Ciò implica, suggerisce Pezzano (ibid.), lo sforzo di sapere interpretare la naturaumana nei termini di Gattungswesen, ossia come “ente naturale generico”: “ente” piuttosto che Essere, poiché la suadefinizione è inevitabilmente relazionale, e “naturale” in virtù della sua costituzione biologico-organica, la quale ne sancisce il carattere “generico”, appunto, ossia non rigidamente predeterminato nei comportamenti, ma intrinsecamente aperto tanto alladimensione della vita storica condivisa quanto al processo di sviluppo di una personalità individuale e singolare. Uninveramento che è una forma di libertà che può realizzarsi soltanto grazie a una comunità che ne definisce di volta in volta limiti e possibilità. Oggi quella comunità è una comunità globale e lo sforzo che le si richiede è quello di identificare limiti epossibilità, tenendo conto non di quanto imposto dai poteri finanziari, ma di quanto necessario al fine di rigenerare l’umanità dell’umanità (Morin, 2002), che significa riuscire a fare appello alla generatività umana, orientandola verso sé stessa: ildiscorso della cittadinanza si fa, così, discorso per la cittadinanza.
Il discorso per la cittadinanza
Favorire questo processo, portare avanti una filosofia del discorso per (a favore di) un’idea di cittadinanza (autenticamente) globale che, definitivamente sottratta a ogni forma di provincialismo culturale, sia capace di scegliere quale proprio ambito diinferenza il mondo (Gennari, 2018) è precisa responsabilità dell’educazione. È questo il senso del target 4.7 di Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’onu7, che promuove esplicitamente un’idea di educazione alla cittadinanza globale orientata a favorire
il senso di appartenenza a una comunità ampia, nella quale la tutela delle relazioni tra esseri umani, ambiente e società e il dialogo costante tra le dimensioni locale, nazionale e globale diventa la chiave della convivenza tra i cittadini di tutto il mondo e della loro relazione con la Terra (asvis, 2022, p. 7).
unesco, organizzazione capofila di questo Target, ha reso operativa questa sfida alla violazione dei diritti umani, alle crescentiineguaglianze e alla perdurante povertà che tuttora minacciano la pace e la sostenibilità nel mondo, supportando gli Stati membrinello sviluppo di curricoli e materiali didattici sui temi della cittadinanza globale (unesco, 2014; 2015, 2018) collaborando conessi ad affrontare le minacce contemporanee ai diritti umani e alla pace, promuovendo principi quali comprensione, nondiscriminazione e rispetto della dignità umana nell’educazione (unesco, 2023; 2024) e offrendo loro un preciso indirizzo sucosa si debba fare oggi per imprimere una nuova direzione al futuro dell’umanità e del pianeta (unesco, 2016; 2021).
Gli esiti attesi (e, in parte, già monitorati da unesco) di queste iniziative di educazione alla cittadinanza globale sono unamaggiore propensione a risolvere i conflitti pacificamente e un più convinto ricorso alla giustizia distributiva. Si tratta, è inutile dirlo, di cambiamenti non banali, che per potersi concretizzare devono essere inquadrati all’interno di un nuovo modo di concepire il contratto sociale (unesco, 2021) che si discosti dalla visione «ristretta, liberale e individualista, inaugurata daThomas Hobbes» (Tarozzi, Milana, 2022, p. 12) per adottarne una più estesa e inclusiva, che implichi, tuttavia, radicali e nonpiù procrastinabili trasformazioni nel sistema socio-economico. In questo senso, globale assume il valore di predicato (κατηγορούμενον) non più rinunciabile di cittadinanza, da intendersi, tuttavia, se non ancora come una verità, come un auspicio al suo avveramento.
- Per un’analisi approfondita del tema cfr. Costa (2001; 2005); D’Alessandro (2006); Rigotti (2006). ↩︎
- Condizione del cittadino autore di un reato che veniva privato, totalmente o parzialmente, dei fondamentali diritti civili. ↩︎
- Si tratta dell’art. 3 della Déclaration des droits de l’homme et du citoyen del 1789; artt. 1 e 2, titolo iii, Costituzione francese del 1791. ↩︎
- Nel Preambolo si legge che la Dichiarazione rappresenta un «ideale comune da raggiungere da parte di tutti i popoli e di tutte le nazioni, affinché ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento, sia fra i popoli degli stessi Stati membri, sia fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione». ↩︎
- I diritti umani di terza generazione sono quei diritti che vanno al di là del mero aspetto civile e sociale, come espresso nella Dichiarazione di Stoccolma del 1972, nella Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano, nella Dichiarazione di Rio del 1992 sull’ambiente e lo sviluppo. ↩︎
- Quest’ultima riguarda, in particolare, la coscienza del legame consustanziale con la biosfera (Maturana, Varela, 1992), intesa come Terra-Patria, matrice e nutrice insieme (Morin, Kern, 1994). ↩︎
- https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/. ↩︎
Bibliografia
- arendt h. (2001), La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, Feltrinelli, Milano.
- asvis (2022), Educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale. Target 4.7, “Quaderni dell’asvis”, 8 (https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/QuadernoASviS_EducazioneSviluppoSostenibile_ott2022.pdf ).
- bateson g. (2000), Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milano.
- bobbio n. (1990), L’età dei diritti. Dodici saggi sul tema dei diritti dell’uomo, Einaudi, Torino.
- carnevale p. (2022), Sulla distinzione fra nazionalità e cittadinanza, in “Italiano digitale”, xxi, 2, pp. 111-5.
- caruso s. (2014), Per una nuova filosofia della cittadinanza, Firenze University Press, Firenze.
- costa p. (2001), Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, Laterza, Roma-Bari.
- costa p. (2005), Cittadinanza, Laterza, Roma-Bari.
- costa p. (2023), Cittadinanza e diritti fra “particolarismo” e “universalismo”: un campo di tensione della modernità, in S. Grassi, M.Morisi (a cura di), La cittadinanza tra giustizia e democrazia, Atti della giornata di studi in memoria di Sergio Caruso, Firenze University Press, Firenze, pp. 45-52.
- d’alessandro r. (2006), Breve storia della cittadinanza, Manifestolibri, Roma.
- ferrajoli l. (2007), Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, Laterza, Roma-Bari.
- forti s. (2010), Totalitarismo, in A. D’Orsi (a cura di), Gli ismi della politica. 52 voci per ascoltare il presente, Viella, Roma, pp. 459-66.
- gennari m. (2018), Filosofia del discorso, Il Melangolo, Genova.
- greco t. (2014), La doppia forza dei diritti. Una riflessione sulle garanzie, in “Metodo. International Studies in Phenomenology andPhilosophy”, 2, 1, pp. 13550.
- kester k. (2023), Global Citizenship Education and Peace Education: Toward a Postcritical Praxis, in “Educational Philosophy andTheory”, 55, 1, pp. 45-56.
- leydet d. (2011), Citizenship, in The Stanford Encyclopedia of Philosophy (http:// plato.stanford.edu/archives/fall2011/entries/citizenship).
- locatelli r. (2019), Reframing Education as a Public and Common Good. Enhancing Democratic Governance, Palgrave Macmillan, Cham.
- maturana h. r., varela f. j. (1992), Macchine ed esseri viventi: l’autopoiesi e l’organizzazione biologica, Astrolabio, Roma.
- morin e. (2001), I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Raffaello Cortina, Milano.
- morin e. (2002), Il metodo. 5: L’identità umana, Raffaello Cortina, Milano.
- morin e. (2005), Il metodo. 6: Etica, Raffaello Cortina, Milano.
- morin e., kern a. b. (1994), Terra-patria, Raffaello Cortina, Milano.
- pezzano g. (2012), Ripensare (con) Marx: la natura umana tra filosofia, scienza e capitale, Petite Plaisance, Pistoia.
- rigotti f. (2006), Recensione a R. D’Alessandro, Breve storia della cittadinanza, in “Jura Gentium. Rivista di filosofia del dirittointernazionale e della politica globale” (https://www.juragentium.org/books/it/dalessan.htm).
- shotter j. (1993), Psychology and Citizenship: Identity and Belonging, in B. S. Turner (ed.), Citizenship and Social Theory, Sage,London, pp. 115-38.
- tarozzi m., milana m. (2022), Reimagining our Futures Together. Riparare le ingiustizie passate per ricostruire la scuola del futuro, in “Quaderni di pedagogia della scuola”, 2, pp. 7-16.
- turner b. s. (ed.) (1993), Citizenship and Social Theory, Sage, London.
- unesco (2014), Global Citizenship Education PreparingLearners for the Challenges of the 21st Century (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/ pf0000227729).
- unesco (2015), Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232993).
- unesco (2016), Incheon Declaration and Framework for Action for the Implementation of Sustainable Development Goal 4: EnsureInclusive and Equitable Quality Education and Promote Lifelong Learning Opportunities for all (https:// unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656/Pdf/245656eng.pdf.multi).
- unesco (2018), Strategia italiana per l’Educazione allaCittadinanza Globale (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261836).
- unesco (2021), Reimagining our Futures Together: a new Social Contract for Education (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707.locale=en).
- unesco (2023), Recommendation on Education for Peace and Human Rights, International Understanding, Cooperation, Fundamental Freedoms, Global Citizenship and Sustainable Development (https://www.unescoaffairs/recommendation-education-peace-and-human-rights-internationalunderstanding-cooperation-fundamental).
- unesco (2024), Mainstreaming Social and Emotional Learning in Education Systems (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000392261).
- vašák k. (1984), Pour une troisième gènèration des droits de l’homme, in C. Swinarski (ed.), Studies and Essays on InternationalHumanitarian Law and Red Cross Principles in Honour of Jean Pictet, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, pp. 837-45.
- vella r. (2022), ‘Is This Really Europe?’ Migration, Social Practice and the Performance of Global Citizenship, in “International Journalof Art & Design Education”, 41, 4, pp. 497-643.
- zamagni s. (2024), Responsabili. Come civilizzare il mercato, il Mulino, Bologna.